
A dieci anni esatti dallo storico Accordo di Parigi, il mondo torna a interrogarsi sulla propria coerenza. A Belém, nel cuore dell’Amazzonia, si apre oggi la COP30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che segna un anniversario simbolico ma anche un passaggio decisivo. Prima dell’avvio formale, previsto per lunedì 10 novembre, i leader globali, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’Italia, si riuniscono per imprimere un impulso politico a negoziati che definiranno la traiettoria climatica del prossimo decennio. La domanda che aleggia è tanto semplice quanto scomoda: stiamo davvero traducendo le promesse in azioni concrete?
Dall’Accordo di Parigi al presente: progresso o illusione?
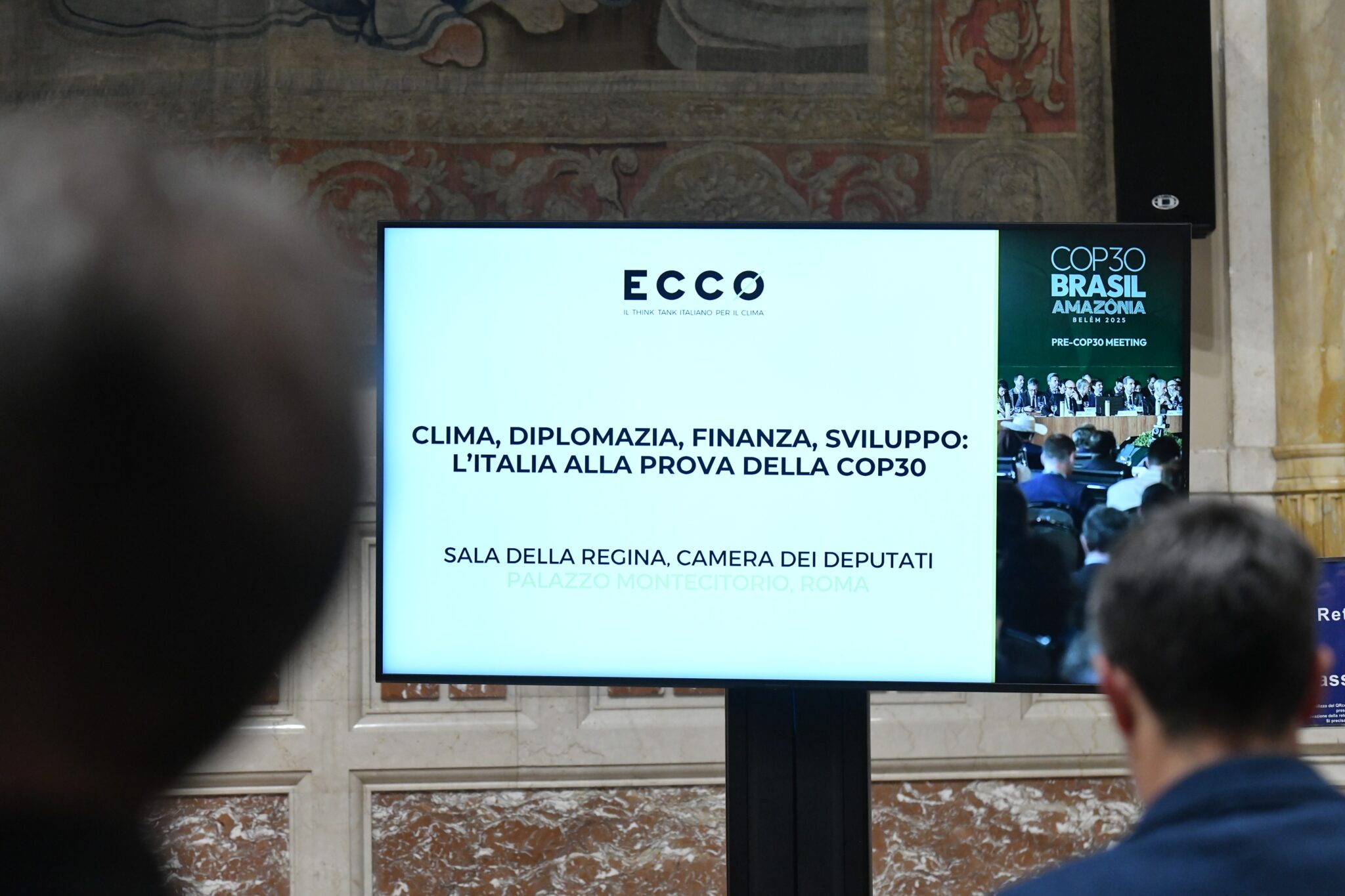
Il mondo del 2025 è molto diverso da quello del 2015. Guerre, crisi economiche e tensioni geopolitiche hanno incrinato la fiducia nel multilateralismo. Eppure, proprio in un contesto di divisione, la COP continua a essere la bussola comune più importante per orientare l’umanità verso un futuro sostenibile. I numeri lo confermano: grazie all’Accordo di Parigi, la traiettoria del riscaldamento globale è scesa da 3,9 a 2,5 gradi. Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica stanno crescendo rapidamente, i costi dell’energia solare e delle batterie si sono ridotti fino al 90%, e gli investimenti globali in energia pulita hanno superato i 2.000 miliardi di dollari l’anno, il doppio di quelli nei combustibili fossili. Ma il tempo stringe: restare sulla rotta dell’1,5°C richiede una trasformazione industriale più veloce, sostenuta da una finanza coerente con gli obiettivi climatici.
L’Europa accelera, ma l’Italia resta in bilico

Alla vigilia della COP30, l’Unione Europea ha fissato un nuovo traguardo: riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040, con un obiettivo intermedio tra il 66 e il 72,5% al 2035. È un impegno che conferma l’ambizione europea, ma non tutti i Paesi si muovono con la stessa decisione. L’Italia ha giocato un ruolo ambiguo, spingendo per un ammorbidimento degli obiettivi e per un uso più esteso dei crediti di carbonio internazionali, che potrebbero minare la trasparenza della transizione.
I dati parlano chiaro: il nostro Paese ha coperto solo il 73% della propria quota equa di finanza climatica e non ha ancora versato i 100 milioni promessi al Fondo Perdite e Danni istituito alla COP28. Sul fronte interno, il Piano nazionale energia e clima mostra ritardi nei settori chiave – trasporti ed edilizia – e una fiscalità ancora troppo favorevole al gas rispetto all’elettrico. Senza una correzione di rotta, l’Italia rischia di perdere competitività e credibilità internazionale.
Biocarburanti e biomassa: il banco di prova della coerenza

Tra i temi più sensibili della COP30 c’è la nuova iniziativa Belém 4x, promossa da Brasile, India, Italia e Giappone, che punta a quadruplicare l’uso di combustibili sostenibili entro il 2035. Un progetto ambizioso, ma anche rischioso: la biomassa, pur essendo una risorsa rinnovabile, è limitata e non può essere impiegata a scapito della sicurezza alimentare o della biodiversità. La sfida sarà definire una gerarchia d’uso intelligente che privilegi gli impieghi a maggiore valore aggiunto – come bioplastiche e materiali bio-based – rispetto alla semplice combustione energetica. La coerenza di questa iniziativa sarà uno dei test politici più rilevanti del vertice.
Un decennio per decidere chi vogliamo essere

La COP30 non è solo una conferenza, ma un bilancio collettivo. Dieci anni dopo Parigi, sappiamo che il cambiamento è possibile: la scienza, l’innovazione e la finanza stanno aprendo la strada a un’economia più pulita e competitiva. Ciò che ancora manca è la volontà politica di seguire con costanza la bussola del clima. Mentre ECCO segue da Belém i negoziati e racconta giorno per giorno il dietro le quinte del vertice, il messaggio è chiaro: la transizione ecologica non è più un’opzione, ma l’unico orizzonte per la sicurezza, l’autonomia e la prosperità globale.



