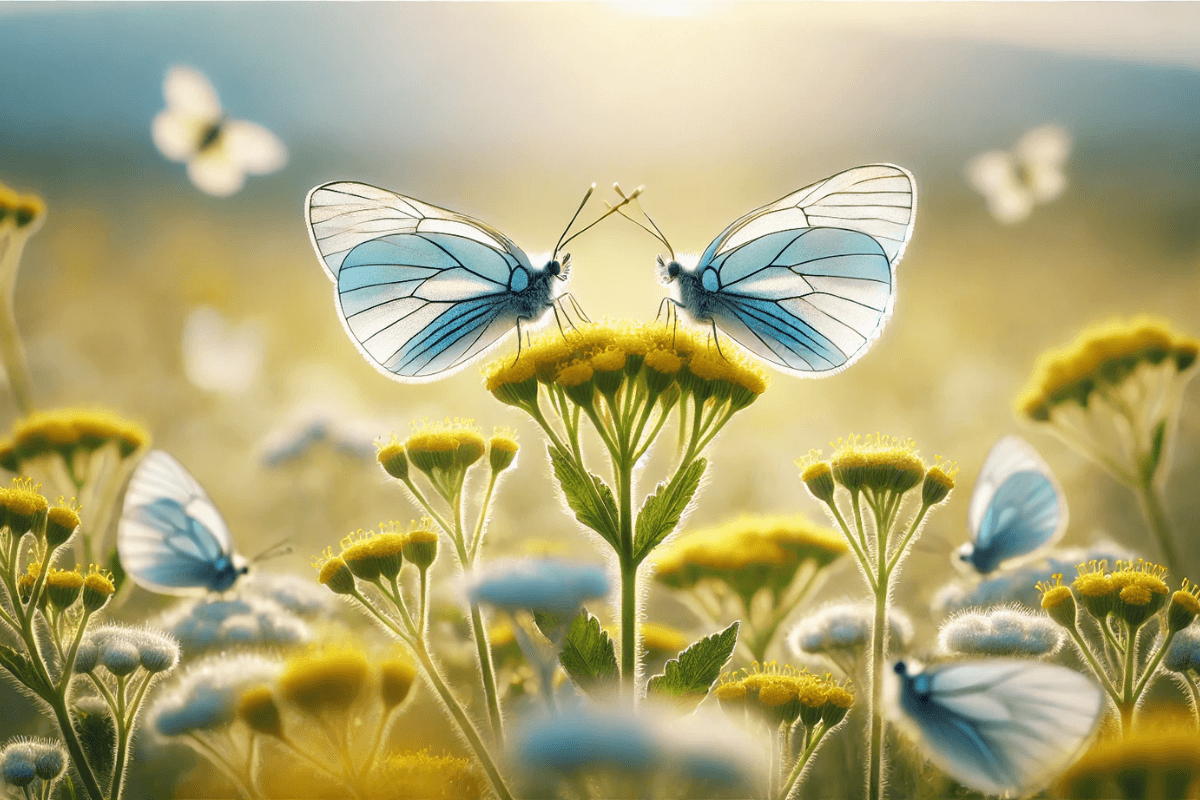
Un declino evidente quello delle farfalle. Ma non stanno semplicemente diminuendo: stanno sparendo, in silenzio. Negli Stati Uniti, tra il 2000 e il 2020, la popolazione è crollata del 22%. Il calo è particolarmente evidente nel sud-ovest — Arizona, New Mexico, Texas — dove la siccità prolungata e l’uso di pesticidi stanno compromettendo molte specie. Nel nord-est, invece, si registra un lieve aumento, grazie ad alcune misure di conservazione.
In Europa, l’Italia è il secondo Paese per biodiversità di farfalle, con 293 specie, ma circa il 9% si considera sotto minaccia e un altro 10% molto vicino a questa soglia. In Asia, Singapore ha perso il 46% delle sue farfalle in 160 anni, mentre in Sud America alcune specie endemiche come Parides ascanius sopravvivono in pochissime aree dell’Amazzonia e sono a rischio critico. Complessivamente, in sintesi, circa il 40% delle specie mondiali è in declino.
Certo, queste percentuali vanno considerate come stime soggette a revisione: i dati disponibili sono molto più completi per Europa e Nord America, mentre in molte altre aree del Pianeta il monitoraggio è ancora frammentario. La reale entità del declino di farfalle potrebbe quindi variare e nuovi studi potrebbero aggiornare queste cifre nei prossimi anni.
Sommario
- Impollinatori trascurati, ma fondamentali
- Il crollo delle reti ecologiche
- La situazione in Europa
- Le cause del declino delle farfalle: più di una minaccia
- Indicatori preziosi della salute ambientale
- Le soluzioni possibili, a partire dal giardino, per evitare il declino delle farfalle
- E se davvero sparissero?
Impollinatori trascurati, ma fondamentali
Il ruolo delle api è ormai ben noto, ma anche le farfalle sono impollinatrici fondamentali. Mentre si nutrono di nettare, trasportano il polline tra piante diverse, facilitando la fecondazione e contribuendo alla riproduzione vegetale. Alcune piante hanno fiori profondi o di forma complessa, che solo la lunga proboscide di una farfalla riesce a raggiungere. Senza queste interazioni, molte specie vegetali perderebbero uno dei loro principali alleati.
Un aspetto da considerare è il ruolo migratorio di alcune farfalle, come la monarca, che percorre migliaia di chilometri attraversando più ecosistemi. Durante questi spostamenti, favorisce la dispersione genetica delle piante, rafforzandone la resilienza agli stress climatici e ambientali. È un’azione silenziosa ma strategica, che rafforza la salute complessiva degli ecosistemi.
Il crollo delle reti ecologiche
Bruchi e farfalle adulte sono una risorsa alimentare chiave per numerosi animali: uccelli, rettili, anfibi, pipistrelli. Durante la stagione riproduttiva, ad esempio, molti uccelli allevano i piccoli nutrendoli quasi esclusivamente con bruchi. Se questi scompaiono, l’intera catena alimentare viene alterata, causando riduzioni di popolazioni, migrazioni forzate e instabilità faunistica.
Questi effetti non si fermano ai boschi o ai prati: anche le aree urbane e agricole ne risentono, perché la perdita di equilibrio ecologico si ripercuote anche su impollinazione, controllo dei parassiti e fertilità del suolo.
La situazione in Europa
Negli ultimi trent’anni, le popolazioni di farfalle di prateria in Europa si sono dimezzate: tra il 1990 e il 2020 si è registrato un calo del 50%, in gran parte dovuto all’agricoltura intensiva, ai cambiamenti d’uso dei suoli e all’abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Solo nell’ultimo decennio, la riduzione è stata del 36%, segno che il declino non si è arrestato ma, anzi, si è aggravato di recente.
Nel Regno Unito, la situazione è particolarmente allarmante: il 2024 è stato uno degli anni peggiori mai registrati per le farfalle, con oltre la metà delle specie in declino a lungo termine e riduzioni significative anche tra le specie un tempo comuni.
Le cause del declino delle farfalle: più di una minaccia
Ma a cosa si deve il declino delle popolazioni di farfalle? Questo fenomeno ha molte cause, spesso concatenate tra loro.
- La perdita di habitat dovuta alla cementificazione, all’agricoltura intensiva, alla deforestazione e alla riforestazione naturale (che cancella ambienti aperti) riduce gli spazi vitali.
- L’uso intensivo di pesticidi, in particolare i neonicotinoidi, compromette ogni fase del ciclo vitale delle farfalle, dalle uova agli adulti.
- I cambiamenti climatici alterano i tempi di sviluppo e disallineano la presenza delle farfalle con le fioriture.
- Le specie invasive, incluse le piante ornamentali non autoctone, sostituiscono quelle che bruchi e adulti utilizzano per nutrirsi o deporre le uova.
- L’inquinamento luminoso interferisce nei comportamenti notturni e nella riproduzione di falene e specie crepuscolari.
- Anche il collezionismo entomologico, seppur marginale, può mettere sotto pressione le specie rare o appariscenti.
Indicatori preziosi della salute ambientale
Le farfalle sono sentinelle della biodiversità: la loro presenza è uno dei primi segnali della qualità di un habitat. Sono sensibili ai cambiamenti chimici, termici e strutturali dell’ambiente, perciò la loro assenza o riduzione è un campanello d’allarme da non ignorare. In Europa, programmi come il Butterfly Monitoring Scheme stanno fornendo dati sempre più accurati sull’impatto delle pratiche agricole, dei cambiamenti climatici e della gestione del paesaggio. In Italia, il monitoraggio sistematico è iniziato nel 2019, ma già mostra segnali preoccupanti in diverse aree collinari e pianeggianti.
Le soluzioni possibili, a partire dal giardino, per evitare il declino delle farfalle
Nonostante la crisi sia grave, le farfalle possono essere salvate. Negli Stati Uniti, progetti di ripristino mirati hanno riportato in natura specie in pericolo grazie a interventi come incendi controllati, rimozione delle piante infestanti e semina di varietà autoctone resistenti.
Anche in ambito urbano o domestico si può fare molto. Coltivare piante amiche delle farfalle come lavanda, buddleja, issopo, fiordaliso, lantana, valeriana rossa e aromi come salvia, rosmarino, origano e timo crea micro habitat funzionali (qui ti spieghiamo quali piante e fiori coltivare per attirare gli impollinatori). Lasciare zone incolte, evitare diserbanti, non falciare troppo spesso: sono azioni semplici che possono trasformare un giardino in un rifugio vitale per gli impollinatori.
E se davvero sparissero?
Senza le farfalle, la Terra sarebbe un luogo meno colorato, ma anche meno produttivo, meno stabile, meno vivo. Le piante impollinate da questi insetti avrebbero una ridotta possibilità di riprodursi, e con il tempo molte specie vegetali potrebbero diminuire fino a scomparire. Le praterie si impoverirebbero, i margini dei boschi perderebbero varietà, e il verde urbano diventerebbe meno ospitale per tutti gli impollinatori.
Gli uccelli che si nutrono di bruchi e insetti dovrebbero cambiare dieta o spostarsi. Le catene alimentari si accorcerebbero, l’equilibrio ecologico si spezzerebbe in punti imprevisti. Anche la produzione agricola potrebbe subire cali, soprattutto nelle colture che beneficiano di una pluralità di impollinatori. La perdita delle farfalle, insomma, non sarebbe solo un colpo alla biodiversità, ma un crollo della complessità biologica che regge la vita sulla Terra.
Non è un futuro lontano. È un rischio concreto, e già visibile in alcune regioni del mondo. Ed è per questo che proteggerle — nei prati, nei parchi, nei giardini — è un gesto semplice ma potente. Le farfalle non sono solo bellezza: sono biologia che lavora in silenzio, per tutti.



