Negli Stati Uniti, non basta insegnare ai bambini a leggere, scrivere e contare. Bisogna anche prepararli a restare vivi. Milioni di studenti statunitensi partecipano regolarmente a esercitazioni antisparatoria: si nascondono sotto i banchi, spengono le luci, chiudono a chiave le porte. I genitori acquistano zaini antiproiettile come normali articoli scolastici, e in alcuni distretti gli insegnanti sono armati per proteggere i propri alunni.
La morte di Charlie Kirk – leader conservatore, attivista pro-Trump, fervente sostenitore del diritto alle armi – va letta all’interno di questo contesto. Colpito a morte da un cecchino il 10 settembre 2025, Kirk non era solo un simbolo del movimento armato americano: era anche una delle sue voci più attive. Il fatto che sia stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco in un Paese che continua a difendere l’armamento diffuso come garanzia di sicurezza personale, rende l’episodio non solo tragico, ma emblematico. Perché in America, nessuno è davvero al sicuro. Nemmeno chi crede fermamente che le armi proteggano.
Simulazioni a scuola
In un’aula di terza elementare del Missouri, gli studenti vengono istruiti a correre verso l’angolo più lontano della stanza, spegnere le luci e tacere. Non è un gioco, non è un esercizio antincendio. È una simulazione di sparatoria, una delle tante previste dai protocolli scolastici americani. Circa il 95% delle scuole pubbliche negli Stati Uniti effettua regolarmente queste esercitazioni – note come active shooter drills – per preparare bambini e adolescenti a una possibile irruzione armata nei loro istituti.
L’origine di queste procedure si colloca dopo la strage di Columbine – nel 1999, due studenti, Eric Harris e Dylan Klebold, entrarono nella loro scuola superiore e aprirono il fuoco contro compagni e insegnanti. Uccisero 13 persone e ne ferirono 23, prima di suicidarsi nella biblioteca.
Da allora, l’adozione delle esercitazioni è diventata prassi, in alcuni casi obbligo di legge: almeno 40 Stati le impongono per legge, e in molti casi sono altamente realistiche. Le luci si spengono, si sentono spari registrati, operatori travestiti da aggressori si muovono nei corridoi. Il risultato è un allenamento alla sopravvivenza, ma anche un potenziale trauma psicologico.

Studi condotti negli ultimi anni hanno sollevato dubbi sull’efficacia e soprattutto sull’impatto emotivo di queste simulazioni. Psicologi ed educatori parlano di ansia crescente, insonnia, percezione di pericolo costante nei bambini più piccoli. Alcuni Stati – come New York – hanno vietato le esercitazioni più estreme, introducendo linee guida per rendere il tutto meno traumatizzante.
A fianco delle esercitazioni, le scuole hanno cominciato ad adottare strumenti e infrastrutture da scenario bellico: finestre blindate rimovibili, sistemi d’allarme avanzati, telecamere intelligenti, pulsanti di emergenza direttamente collegati alle forze dell’ordine. In alcuni distretti, vengono installati scanner biometrici all’ingresso e si vieta l’accesso ai genitori senza autorizzazione digitale.
A tutto questo si aggiunge l’assurda presenza degli zaini antiproiettile. Venduti come normali accessori scolastici – con colori pastello, tasche multiple e spazio per i libri – costano in media 200 dollari e sono realizzati per resistere a colpi di pistole o fucili semiautomatici. Alcuni modelli dichiarano una resistenza fino ai proiettili 7.62 mm. Non garantiscono la sopravvivenza, ma offrono “una chance in più”, come recita una delle pubblicità.
Più armi per sentirsi al sicuro

Il diritto a possedere armi è scolpito nel Secondo Emendamento della Costituzione statunitense. È un pilastro identitario, tanto potente quanto divisivo. Ma se la legge federale prevede controlli sui precedenti penali (i cosiddetti background check), l’applicazione concreta varia enormemente da Stato a Stato, generando un mosaico normativo che rende difficile una gestione unitaria del problema.
Alcuni stati – come Texas o Arizona – permettono il porto d’armi senza permesso, sia in modalità visibile sia nascosta. Altri, come la California o il Connecticut, hanno tentato per anni di mantenere restrizioni più severe, ma la Corte Suprema ha recentemente limitato il margine di manovra degli Stati, rafforzando il diritto individuale a portare armi in pubblico. La decisione ha aperto un ulteriore varco normativo che ha reso ancora più difficile il contenimento dell’accesso alle armi da fuoco.
Nel frattempo, le red flag laws, pensate per rimuovere temporaneamente le armi a soggetti ritenuti pericolosi, faticano a essere applicate in modo coerente. Le ghost guns – armi assemblabili senza numero di serie – si diffondono rapidamente nonostante i tentativi di regolamentazione. E le scuole, paradossalmente, sono spesso escluse dalle zone di divieto, oppure lo sono solo sulla carta.
La retorica di Trump
In questo scenario si inserisce con forza la figura di Donald Trump, presidente in carica nel 2025, che ha fatto del diritto alle armi un elemento centrale della sua agenda politica. Il suo programma Project 2025 e il manifesto Agenda 47 prevedono, tra le altre cose, l’armamento diffuso del personale scolastico: insegnanti armati, veterani e agenti in pensione da inserire nelle scuole con stipendi finanziati dallo Stato. In cambio, la promessa di una “protezione efficace”, senza bisogno di riforme restrittive.
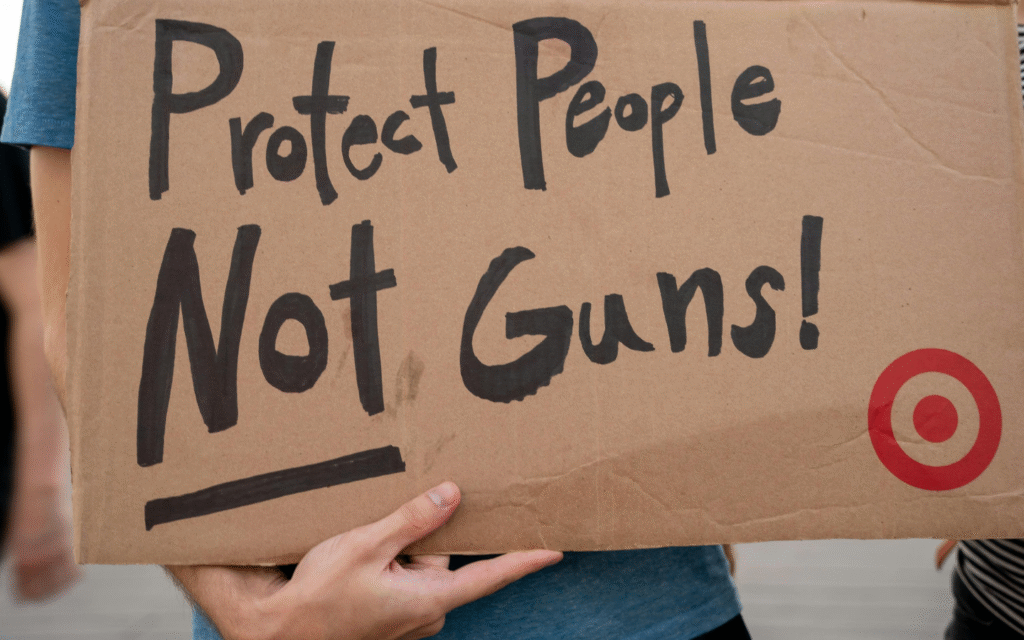
Una cultura che si nutre di paura e produce accettazione
Quando un’intera generazione cresce imparando a nascondersi prima ancora di esprimersi, la questione non è più soltanto politica o legislativa: diventa culturale. Il diritto alle armi, promosso come fondamento della libertà individuale, ha colonizzato la quotidianità americana a tal punto da essere percepito come una condizione inevitabile, addirittura naturale.
Chi si oppone a questo modello viene spesso tacciato di voler “disarmare l’America”, come se il rischio non fosse la proliferazione delle armi ma la perdita di un’identità nazionale. Il dibattito pubblico si è così spostato dal se sia giusto armarsi, al come farlo meglio. Un cambio di paradigma che rende ogni evento tragico – anche la morte di chi, come Charlie Kirk, ha fatto delle armi una bandiera – un’altra pagina da voltare, mai da rileggere.




